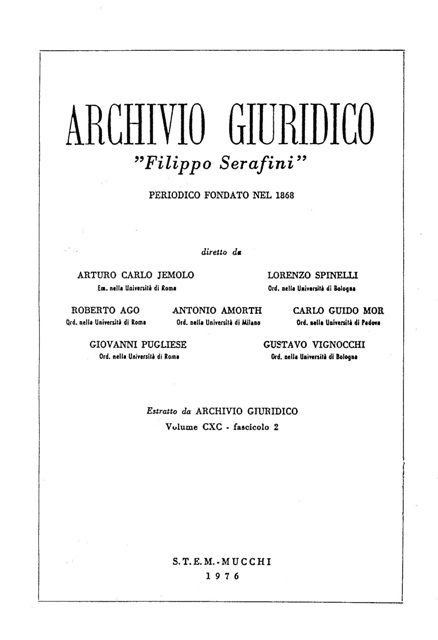Neri Capponi
Assistente Ordinario di diritto canonico nell’Università di Firenze
ALCUNE CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
IN MATERIA DI RIFORMA LITURGICA
I
Il Concilio Vaticano II dato il suo carattere pastorale non poteva tralasciare di considerare il campo liturgico centro della vita spirituale della comunità ecclesiastica e pertanto luogo precipuo dell’azione pastorale della Chiesa.
L’interesse per la liturgia si era del resto manifestato abbondantemente nei decenni che precedettero il Vaticano II soprattutto ad opera della parte migliore del movimento liturgico nato all’indomani della riforma-restaurazione di Pio X. Il movimento liturgico infatti sia con il suo lavoro di indagine e di ricerca che attraverso la maggiore sensibilizzazione dei fedeli ai riti della Chiesa aveva smosso la stessa autorità ecclesiastica ad interessarsi maggiormente al problema per cui prima con la enciclica “Mediator Dei” (1947), poi con la riforma della Settimana Santa terminata nel 1955, la stessa Santa Sede fu cointeressata agli scopi del movimento liturgico e soprattutto a quello che si proponeva una maggiore vitalizzazione del culto pubblico della Chiesa.
Di tutto questo il Concilio non poteva non tener conto in una visione di riforma-restaurazione dell’intera liturgia e questi precedenti possono inoltre in parte [1] spiegare il relativo successo dello schema liturgico, presentato nell’aula conciliare il 22 ottobre 1962. Infatti su settanta progetti previsti, di cui venticinque furono distribuiti all’apertura del Concilio, soltanto lo schema sulla liturgia sfuggi alla rifusione e venne sostanzialmente accolto. Il Concilio lo ritenne come base di discussione e, pur con molte modifiche, lo approvò, nell’anno successivo, il 4 dicembre 1963 con 2.151 voti.
Il problema fondamentale che si presentò al Concilio fu quello di mantenere un equilibrio fra il passato ed il futuro, promuovendo in pari tempo il progresso e lo sviluppo delle forme liturgiche senza rottura della linea tradizionale e soprattutto senza avventure. Il documento conciliare parla infatti di “instauratio”, di restaurazione, non di un semplice ritorno alle forme originarie o primitive (che sarebbe stato in tal caso pura riesumazione di riti e di forme archeologiche), né di creazione di nuove forme perché avremmo allora avuto una nuova liturgia, distruzione e superamento di quella esistente. “Restaurazione” significa cauta revisione, verifica non eversiva della validità di certi riti di istituzione meramente ecclesiastica e, se necessario, l’eventuale inserimento, organico ed armonioso, di qualche nuovo elemento nel complesso esistente. Una riforma che, nell’assoluto rispetto della tradizione, tendeva a facilitare la maggiore comprensione e partecipazione del popolo cristiano alla liturgia. Da notare inoltre che mentre il Concilio tridentino si era limitato a suggerire genericamente, demandandola al Papa, una riforma del messale e del breviario, il Vaticano II aveva voluto esprimere anche i modi concreti di attuazione delle riforme.
Subito dopo la promulgazione della Costituzione sulla liturgia, il 25 gennaio 1964, il Papa emanava il Motu Proprio “Sacram Liturgiam”, con il quale stabiliva l’attuazione immediata di alcune disposizioni della medesima Costituzione ed annunciava la nomina di una speciale commissione per studiare le modalità di applicazione del documento conciliare. Il 29 febbraio successivo, approvato il progetto della commissione da parte del Papa, fu istituito il Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia presieduto dal Cardinale Giacomo Lercaro.
Fu chiaro con la nomina di questo Consilium che si intendeva sottrarre alla normale competenza della S. Congregazione dei Riti ogni e qualsiasi questione riguardante la riforma della liturgia in ciò forzando per la prima volta le indicazioni dei Padri conciliari che si erano limitati a raccomandare assai vagamente nell’articolo 25 della Costituzione che “i libri liturgici siano riveduti quanto prima, servendosi di persone competenti e consultando vescovi di diversi paesi del mondo”, con ciò non escludendo affatto la competente Congregazione, sia pure facendo voto affinché anche l’episcopato mondiale fosse fatto partecipe dei lavori.
Si è avanzato il dubbio che i novatori più accesi, sconfitti nell’aula conciliare, avessero puntato sulla creazione di questo nuovo organismo per ottenere quella riforma radicale a cui il Concilio non era stato propenso; sta di fatto che i conflitti di competenza fra la S. Congregazione dei Riti ed il nuovo Consilium non tardarono a manifestarsi per cui il Pontefice credette opportuno intervenire per precisare l’ambito delle rispettive competenze, a favore soprattutto del nuovo organismo, prima con un discorso ai componenti del Consilium il 20 ottobre 1964 poi con una lettera al prefetto della S. Congregazione dei Riti del 7 gennaio 1965 ed infine, non cessando i conflitti, con un discorso ai mèmbri del Consilium del 13 ottobre 1966. Dagli interventi pontifici si può dedurre che al Consilium spettava: 1) lo studio dei testi liturgici secondo quanto aveva prescritto il Concilio; 2) l’emanazione delle disposizioni relative agli esperimenti liturgici; 3) la conferma degli atti delle conferenze episcopali in esecuzione dell’articolo 3 della Costituzione liturgica. Alla S. Congregazione dei Riti, d’intesa con il Consilium, :sarebbe spettato: 1) la promulgazione degli atti che davano efficacia alle norme ed ai testi preparati dal Consilium; 2) la vigilanza e l’interpretazione ufficiale delle nuove forme liturgiche. Indubbiamente così il Consilium, formato quasi esclusivamente di novatori con la presenza attiva anche di membri di confessioni cristiane acattoliche, acquistava una posizione di assoluta preponderanza subordinando a sé l’antico organismo curiale.
Poiché oggetto di questo studio è la rilevanza giuridica della riforma del messale e dell’introduzione nei riti della lingua volgare al posto del latino, sarà bene esaminare l’attività del Consilium in relazione a questi due caposaldi della rivoluzione liturgica attuata al di là ed anche contro le disposizioni conciliari.
Il primo documento in materia la Istruzione “Inter Oecumenici” del 26 settembre 1964, entrato in vigore il 7 marzo 1965 può dirsi il primo ed unico atto preparato dal Consilium che abbia, nel complesso, rispettato quanto meno lo spirito della Costituzione conciliare. La Istruzione introduceva l’uso facoltativo della lingua volgare in tutti i riti, e, per quanto riguardava la Messa, in tutte le sue parti eccetto il prefazio ed il canone; sempre riguardo alla Messa l’Istruzione stabiliva l’accorciamento o l’omissione di alcune preghiere alla fine ed al principio del rito nonché l’abolizione di alcuni sacri segni ed elementi di cerimoniale, dava maggiore spazio alla liturgia della parola riintroducendo l’orazione dei fedeli prima dell’offertorio; infine, per la prima volta, attribuiva precisi poteri liturgici alle conferenze episcopali. La seconda Istruzione “Tres abhinc annos” del 4 maggio 1967 aveva carattere più rivoluzionario dirigendo la sua attenzione alla parte centrale e più sacra della Messa, la preghiera eucaristica o canone, ove veniva concessa la recitazione ad alta voce e soprattutto l’uso del volgare ed inoltre venivano aboliti quasi tutti i gesti o segni sacri sia nel canone che nelle altre parti del rito. L’estensione facoltativa del volgare a tutta la Messa veniva certamente a contrastare con i disposti dell’articolo 36 paragrafi 1 e 2 della Costituzione liturgica che aveva, soprattutto nel secondo paragrafo del suddetto articolo, previsto un uso assai più limitato del volgare di quanto invece veniva reso possibile dalle due Istruzioni e soprattutto dalla seconda.
Altre due Istruzioni, “Musicam Sacram” del 7 marzo 1967 ed “Eucharisticum Mysterium” del 25 maggio 1967, oscillarono fra rivoluzione (soprattutto la seconda) e conservazione essendosi in parte già presentati i problemi nati dalle riforme promosse dalle due precedenti Istruzioni: problemi di ordine musicale, che non potevano non sorgere coll’abbandono del latino e perciò del canto gregoriano a quella lingua indissolubilmente legato, e problemi di ordine teologico in ordine alla minore sacralità del rito eucaristico avutosi soprattutto con l’accentuazione del carattere di “cena” della celebrazione rispetto a quello di “sacrificio”, con l’uso generalizzato del volgare e coll’abolizione quasi totale di quei “sacri segni” che sottolineavano lo svolgimento del rito stesso. Peraltro un po’ alla chetichella prendeva avvio una completa ristrutturazione dell’intera liturgia e soprattutto del rito della messa, momento centrale del culto cristiano. Tale messa riforma ta sotto il titolo di “missa normativa” veniva presentata all’approvazione del Sinodo dei Vescovi il 21 ottobre 1967 che peraltro sostanzialmente la respinse, nella votazione tenuta il 26 ottobre, con 104 voti negativi (non placet et placet iuxta modum) e 10 astensioni contro 72 voti favorevoli [2].
Nonostante il voto contrario del Sinodo i novatori del Consilium riuscirono a far promulgare la “missa normativa” con la Costituzione Apostolica “Missale Romanum” del 3 aprile 1969: il nuovo messale era inoltre accompagnato da una Institutio Generalis, o collezione di definizioni e di rubriche, preposta al testo vero e proprio del nuovo messale quasi un’introduzione teologico-normativa. Sia il nuovo messale che la Institutio Generalis furono promulgate il 6 aprile 1969 ed il 25 maggio successivo fu promulgato dalla S. Congregazione dei Riti “l’Ordo lectionum” della nuova messa in volume separato dal messale vero e proprio, ribadendosi dal medesimo sacro dicastero che l’entrata in vigore sia del messale che del lezionario sarebbe avvenuto il 30 novembre 1969. L’8 maggio 1969 con la Costituzione Apostolica “Sacra Rituum Congregatio” furono create al posto dell’antica S. Congregazione dei Riti due nuove congregazioni l’una per le Cause dei Santi, l’altra per il Culto Divino: la seconda succedeva nelle competenze liturgiche dell’antico dicastero assorbendo il Consilium che cessando così di esistere eliminava il preesistente dualismo. Infine con la Istruzione “De modo Sanctam Communionem ministrandi” del 29 maggio 1969 si ponevano cautamente le premesse per la distribuzione della Comunione nella mano secondo l’uso introdotto dai riformatori protestanti nel XVI secolo.
Nel frattempo le perplessità sia teologiche che giuridiche nei confronti del nuovo testo cominciarono a manifestarsi. Il carattere scarsamente giuridico (quanto meno nello stile) della Costituzione Apostolica nonché le profonde ed equivoche modifiche subite dal rito, modifiche rese ancor più inquietanti da alcune definizioni come quella che veniva data della Messa nel paragrafo 7 della Institutio Generalis [3], suscitarono una valanga di critiche, alcune autorevolissime. Infatti il 5 giugno 1969 usciva, ad opera di qualificati teologi, un “Breve esame critico del novus ordo missae” in cui si facevano con scrupolo, precisione e dettaglio rilevare i numerosi equivoci teologici del nuovo rito che sostanzialmente metteva in sordina tre verità fondamentali su cui poggia il rito cattolico della messa: il carattere di sacrificio propiziatorio, la presenza reale di Cristo nell’Eucarestia, il sacerdozio ministeriale istituzionalmente distinto dal sacerdozio universale dei fedeli. Particolarmente presi di mira dal “Breve esame critico” furono: la definizione di Messa nel citato paragrafo 7 e nel susseguente paragrafo 8 [4], le nuove preci eucaristiche, il nuovo offertorio, l’eccessiva rilevanza data alla liturgia della parola, la pratica abolizione del latino, l’introduzione della donna come ministro della liturgia della parola, ecc. Grande valore a questa protesta ufficiale fu data dalla sua presentazione al Papa attraverso una pubblica lettera dei Cardinali Ottaviani e Bacci nella quale i firmatari sostennero che il novus ordo missae: “rappresenta, sia nel suo insieme come nei particolari, un impressionante allontanamento dalla teologia cattolica della Santa Messa”. Inoltre era da registrare l’opposizione di quasi tutti gli episcopati a scadenze troppo ravvicinate per l’entrata in vigore del nuovo messale a causa della difficoltà di effettuare in così breve tempo le traduzioni in lingua vernacola a cui la Santa Sede aveva voluto legare l’entrata in vigore del messale stesso.
Primo effetto di codeste gravi critiche ed opposizioni fu la modifica in senso più ortodosso dei punti più controversi della Institutio Generalis e la emanazione di una nuova normativa che protraeva fra l’altro l’entrata in vigore del novus ordo missae. Infatti la successiva Istruzione generale del 20 ottobre 1969 intitolata “De Constitutione Apostolica ‘Missale Romanum’ gradatim ad effectum deducenda”, considerando che l’esecuzione del nuovo rito “non paucas neque parvas difficultates prae se fert”, spostava l’entrata in vigore del nuovo messale dal 30 novembre 1969 al 28 novembre 1971 facendo dipendere dalle varie conferenze episcopali (incaricate anche delle traduzioni in lingua vernacola) un’entrata in vigore precedente a quella data: l’Istruzione peraltro specificava che fin dal 30 novembre 1969 sarebbe stato lecito adoperare il nuovo rito; infine ai sacerdoti anziani od infermi veniva permesso di usare il vecchio rito per la celebrazione di messe “sine populo” anche dopo il 28 novembre 1971. Il Papa intanto con le allocuzioni del 19 e del 26 novembre 1969 cercava di tranquillizzare i fedeli, arginando con argomentazioni varie l’ondata delle critiche fino a dichiarare che i riti e le conseguenti rubriche liturgiche non costituivano definizioni dogmatiche per cui avevano un valore relativo; inoltre nella allocuzione del 26 novembre il Pontefice nel riferire le norme di applicazione del novus ordo missae si premurava di riportare le indicazioni provenienti “dall’officina competente cioè la Sacra Congregazione per il Culto Divino” quasi a distaccare la propria responsabilità da quella del dicastero competente; il Papa inoltre ribadiva la priorità dell’uso del latino sulla lingua vernacola nella celebrazione del rito. Finalmente il 26 marzo 1970 veniva pubblicata una nuova edizione critica del nuovo messale e della Institutio Generalis ove fra gli altri cambiamenti risultava anche modificato in senso più ortodosso il contrastato e già citato paragrafo 7, consacrando così la prima vittoria di coloro che si erano opposti al nuovo rito; inoltre il decreto di promulgazione della nuova edizione non faceva più menzione di una data fissa dalla quale avrebbe iniziato a vigere il nuovo messale il cui uso peraltro era fin da allora permesso purché in lingua latina.
Poiché l’opposizione non accennava a diminuire e d’altra parte, avendo il nuovo rito aperto la strada ad ulteriori, non autorizzate e rivoluzionarie innovazioni, la S. Congregazione del Culto Divino emanava [5] il 5 settembre 1970 una nuova Istruzione ove, dopo aver preso atto che alcuni “veteris servandae traditionis causa, huiusmodi reformationes aegre acceperunt” tentava con una serie di disposizioni restrittive di imporre un freno alle innovazioni più ardite.
Finalmente il 14 giugno 1971 con una Notificatio della Sacra Congregazione del Culto Divino si abbandonava definitivamente il criterio della scadenza fissa imposta da Roma per l’entrata in vigore del nuovo messale e del nuovo breviario o liturgia delle ore lasciando di ciò arbitro le conferenze episcopali. Alle conferenze episcopali, protagoniste assolute della Notificatio, veniva accordata la facoltà di stabilire quando le nuove versioni in lingua vernacola avessero dovuto o potuto usarsi (“possint vel debeant”), limitandosi la S. Congregazione a prescrivere l’esclusivo uso del nuovo messale anche in lingua latina con l’entrata in vigore obbligatoria delle nuove versioni vernacole in quanto stabilita dalle varie conferenze episcopali; alle medesime veniva inoltre accordato, con disposizione veramente rivoluzionaria, la facoltà di prescrivere l’uso totale della lingua vernacola nelle messe “cum populo”, in altre parole il permesso di interdire l’uso pubblico della lingua latina rovesciando così la normativa conciliare.
L’opposizione, rinfocolata da queste nuove disposizioni che provocavano l’unione indissolubile fra l’azione per la ritenzione come rito facoltativo del vecchio messale di Pio V e l’azione per la preservazione del latino come lingua liturgica, continuava a manifestarsi in varie forme sostenendo essere illegali le disposizioni dell’ultima Notificatio e non essere abrogato l’antico messale. A questa opposizione, di fronte al silenzio del Pontefice, la S. Congregazione rispondeva con una seconda Notificato del 28 ottobre 1974 che mentre sull’uso del latino sembrava, con frase alquanto generica, ritornare all’uso facoltativo assoluto delle due lingue, latina e vernacola, quale era stato nel periodo che va dalla Instructio Altera del 4 maggio 1967 alla Notifìcatio del 14 giugno 1971, ribadiva essere il nuovo messale il solo in vigore (con le solite eccezioni per i sacerdoti vecchi o ammalati) “nonobstante praetextu cuiusvis consuetudinìs etiam immemorabilis” con ciò cercando di colpire (senza peraltro dimostrarne l’infondatezza) la argomentazione giuridica principe di coloro che sostengono essere ancora in vigore l’antico messale di San Pio V.
II
Per meglio intendere gli aspetti giuridici della vasta, caotica e contraddittoria legislazione che ha accompagnato e seguito le modifiche di struttura dell’atto centrale del culto cattolico, la Messa, sarebbe non inopportuno gettare uno sguardo sull’origine e lo sviluppo di questo importante rito.
Il rito della messa deriverebbe da quello della cena comunitaria ebraica, la chabûrah, e in ogni caso, certamente, da quello della cena pasquale [6], preceduto da un’introduzione catechetica cioè da un complesso di preghiere e di letture della Sacra Scrittura che era ne più ne meno l’essenza del servizio divino festivo in una sinagoga [7]: all’inizio questi due elementi (la cena, o quanto meno il rito essenziale della stessa e la sinassi od assemblea liturgica) erano distinte, ma nel corso del V secolo quasi ovunque si fusero, la sinassi precedendo l’eucaristia.
Per quanto riguarda la celebrazione dell’eucaristia essa fin dalla fine del primo secolo si era separata dalla cena vera e propria per cui la settemplice azione del Cristo, quasi simile a quella di ogni capo mensa giudaico, cioè: 1) “prese il pane”, 2) “rese grazie”, 3) “lo spezzò”, 4) “lo distribuì dicendo alcune parole”, 5) “poi prese il calice”, 6) “rese grazie”, 7) “lo passò ai suoi discepoli dicendo alcune parole” (trovandosi le prime quattro azioni al principio della cena e le ultime tre alla fine), viene enucleata dalla cena stessa e si ridusse a 4 azioni: 1) “l’offerta del pane e del vino”, 2) “la preghiera di ringraziamento di colui che presiede l’assemblea sulle offerte”, 3) “la frazione del pane”, 4) “la comunione o distribuzione del pane e del vino consacrati agli astanti” [8]. La preghiera, poi, del ringraziamento, pronunciata alla fine del pasto dal capo mensa giudaico per la benedizione della coppa o calice, di cui la cosidetta preghiera sacerdotale del Cristo riportata da S. Giovanni [9] è il modello cristiano, servì, nel rito enucleato, per la consacrazione sia del pane che del vino, previa inserzione delle parole riguardanti la specifica consacrazione del pane che così si trovarono unite a quelle riguardanti quella del vino.
I due riti (della sinassi e dell’eucaristia) così si presentavano prima della loro fusione completa anche quando, come già nel IV secolo, essi venivano celebrati spessissimo insieme: uno (sinassi) come preparazione all’altro (eucarestia) secondo il seguente schema [10]:
Sinassi
a) saluto del Vescovo e risposta del popolo;
b) lezioni scritturistiche;
c) intramezzate da salmodia;
d) omelia del Vescovo;
e) rinvio dei catecumeni;
f) preghiera dei fedeli;
g) rinvio dei fedeli se non seguiva la celebrazione eucaristica.
Eucaristia
a) saluto del vescovo e risposta del popolo;
b) bacio della pace;
c) offertorio;
d) preghiera eucaristica contenente le parole sacramentali della istituzione;
e) frazione del pane;
f) comunione;
g) rinvio.
La sinassi nei primi tempi poteva, come si è visto, essere frequentata anche da catecumeni od anche da pagani interessati; il suo scopo non era solo quello di riunire i fedeli in preghiera ma altresì di istruire i catecumeni ed interessare i pagani alla dottrina ed al culto cristiano, solo l’ultima parte che si chiamava “preghiera dei fedeli” era appunto riservata solo a questi ultimi; l’eucaristia era invece riservata solo ai fedeli e rigorosamente interdetta agli estranei, si trattava infatti della celebrazione del mistero cristiano dal quale erano altresì esclusi i pubblici peccatori.
Nella Chiesa del V secolo ed in quella dei secoli successivi, quando ormai anche l’eucaristia si celebrava in pubblico, la sinassi, come abbiamo detto, si fuse completamente con la eucaristia, vennero aggiunti nuovi elementi e si spostarono o furono aboliti alcuni esistenti [11].
Poiché a noi interessa il rito romano, è l’evoluzione della Messa in occidente e soprattutto a Roma che intendiamo seguire. Nel rito romano vengono successivamente introdotti, prima del saluto del Vescovo o del Sacerdote celebrante delegato del Vescovo; il canto d’entrata o introito, le litanie (più tardi rimpiazzate del kyrie), l’inno (Gloria in excelsis); dopo il saluto del celebrante fu introdotta una preghiera, detta poi “colletta”, perché il celebrante riassumeva in un unico “oremus” la preghiera di tutta la comunità. Col saluto del celebrante e con la colletta iniziava la sinassi vera e propria consistente come sempre di letture dalla Sacra Scrittura intercalate da salmi interlezionari; seguiva poi l’omelia seguita a sua volta dall’antichissimo congedo dei catecumeni dopo il quale iniziava la preghiera dei fedeli che chiudeva così la sinassi [12]. Con la fusione fra sinassi ed eucarestia, a causa anche della celebrazione pubblica di quest’ultima che si inizia col V secolo, nel rito romano caddero a poco a poco in desuetudine sia il congedo dei catecumeni (che sopravvive in oriente anche ai giorni nostri) che la preghiera dei fedeli, cambiamenti avvenuti fra il V ed il VI secolo. Sempre all’inizio del V secolo e sempre come conseguenza della fusione fra sinassi ed eucaristia, il bacio della pace fu trasferito a dopo la frazione del pane, prima cioè della comunione, ove si trova tutt’ora; nel VII secolo fu aggiunta la recita dei tre “Agnus Dei” prima della comunione; ultima aggiunta alla ormai unificata celebrazione della sinassi e dell’eucarestia che costituisce la nostra messa fu il “Credo”, aggiunto dopo l’omelia nell’XI secolo [13]. Nei secoli dopo Costantino si sviluppa altresì il cerimoniale che accompagna le celebrazione eucaristica: le incensazioni, l’uso delle candele, delle croci, la ricchezza delle vesti, le insegne di potestà o dignità, i gesti rituali ecc.; contemporaneamente si sviluppa anche il calendario liturgico con la conseguenza che accanto alle parti immutabili (le più importanti) si cominciano ad avere i “propri”, preghiere, canti, salmi e letture “proprie” del giorno e che mutano col calendario liturgico [14].
Quello che preme qui sottolineare è lo sviluppo assolutamente spontaneo della liturgia e di quella eucaristica in particolare di cui moderatori erano i singoli vescovi, nessuna legislazione uniforme, nessuna imposizione dall’alto ma una consuetudine che intorno al nucleo centrale immutabile, perché di diritto divino, dell’eucarestia si sviluppava, sia per la libera inventiva del celebrante sia soprattutto per l’imitazione delle forme in uso nelle chiese più antiche ed autorevoli. Così mentre nei primi secoli assistiamo ad una influenza della sede romana seguita da quella di Alessandria ed in terzo luogo da quella di Antiochia, dopo Costantino grande autorità in materia è esercitata dalla sede di Gerusalemme, influenza che si estenderà per tutti i secoli IV, V e VI cedendo, in oriente, a poco a poco alla supremazia liturgica della chiesa imperiale di Costantinopoli. In occidente invece accanto alla influenza gerosolimitana si fa sentire sempre più quella della sede romana che a poco a poco diventa assolutamente prevalente rispetto anche alle altre chiese locali d’occidente. Verso il V secolo cominciò l’uso, sopratutto da parte della sede romana, di raccogliere la tradizione e le consuetudini liturgiche in collezioni scritte dette sacramentari così fissando la consuetudine stessa: di questi sacramenti si ricordano il Leoniano, il Gelasiano e (più importante di tutti) il Gregoriano sorto dalla riforma-stabilizzazione liturgica di Gregorio Magno [15].
La definitiva stabilizzazione della liturgia eucaristica e del calendario operata da Gregorio Magno [16] non riguardava peraltro che il rito romano né Papa Gregorio mai pensò di imporre la liturgia romana ad altre parti dell’orbe cattolico. Questo è tanto vero che nelle istruzioni date ad Agostino di Canterbury, capo della missione inglese inviata dallo stesso Gregorio, il Papa consiglia di prendere quanto vi possa essere di meglio nel rito romano e nei riti gallicani per formare attraverso un nuovo rito misto la consuetudine liturgica degli anglosassoni [17]; lo stesso riverente rispetto per altri riti è dimostrato dal santo pontefice nei riguardi del rito milanese e ravennate [18].
Se la fine del IV° secolo aveva visto il delinearsi di una specifica liturgia “occidentale” nel quadro dell’antica tradizione della Chiesa universale, il V secolo vede l’adattamento di questa particolare tradizione liturgica al culto pubblico ed il formarsi del calendario liturgico ed il VI secolo lo evolversi nel quadro della stessa specifica tradizione occidentale di vari tipi di liturgie regionali in Gallia, Spagna e Italia. Il VII secolo segna un periodo di crisi ma il cammino dell’evoluzione liturgica riprende nelI’VIII ove s’inizia una nuova sintesi che troverà il suo completamento nel X secolo. È nel regno franco che la sintesi s’inizia, nell’ambito di quella liturgia gallicana che aveva già potentemente sentito l’influenza di Roma attraverso la importazione del sacramentario Gelasiano. Per la prima volta nella storia dell’occidente si assiste al tentativo di imporre una uniformità liturgica e ciò non ad opera della Chiesa né tanto meno della chiesa romana, ma dell’autorità civile impersonata da Carlo Magno [19]. Avendo l’imperatore deciso per l’uniformità liturgica nell’ambito dell’impero, scelse per questo scopo, ovviamente, il rito romano affidando la esecuzione del suo disegno al grande Alcuino [20]. Peraltro Alcuino nel promulgare i nuovi libri liturgici che dovevano servire a tutte le chiese dell’impero e che erano sostanzialmente il sacramentario Gregoriano rivisto e corretto, conscio che il rito romano era troppo scarno e severo per incontrare il favore incondizionato dei popoli nordici aggiunse ad esso un supplemento tratto dalla liturgia gallicana contenente preghiere e rubriche per cerimonie od occasioni care alla pietà nordica: mentre il testo gregoriano veniva reso obbligatorio, il supplemento era di uso facoltativo, ma ben presto le due parti di ciò che potremmo chiamare il messale di Alcuino si fusero in una dando origine al nuovo messale della chiesa di occidente.
Tutti questi mutamenti, peraltro, sono sempre all’insegna della norma consuetudinaria, poiché, a parte la discutibilità giuridica della normativa carolingia trattandosi dell’usurpazione evidente da parte del potere civile di funzioni squisitamente religiose (e la sua non accettazione a Roma ne è la riprova), il messale di Alcuino (nella sua forma modificata dall’uso) incontrò il favore di moltissime chiese dell’impero perché rappresentava una sintesi liturgica che ben si accompagnava alla sintesi politica carolingia.
In fine la restaurazione imperiale ad opera degli Ottoni riimportò a Roma il messale di Alcuino il quale sostituì nel X ed XI secolo il vecchio messale gregoriano [21]. I francescani nel XIII e XIV secolo provvederanno poi a rendere comune nell’occidente il nuovo messale romano. Nel corso di queste evoluzioni si hanno le ultime aggiunte cioè: le preghiere sacerdotali iniziali ai piedi dell’altare, le preghiere sacerdotali dell’offertorio [22], l’ultimo vangelo dopo la benedizione finale e, nel XII secolo, anche come risposta agli eretici che contestavano il dogma della presenza reale, l’elevazione delle sacre specie alla consacrazione [23].
Questo era il complesso dei libri liturgici per la celebrazione della eucaristia che il Concilio di Trento trovò in uso a Roma e nella maggior parte dell’occidente cristiano sia pure qua e là con adattamenti particolari o locali di non grande importanza e fu questa collezione che Pio V unì in un unico libro o messale aggiungendo alla esistente forza della norma consuetudinaria la sanzione della legge positiva con la Bolla “Quo Primum” del 19 Luglio 1570 che estendeva il rito romano all’intera Chiesa. Con l’atto legislativo di Pio V, il primo del suo genere nella storia della Chiesa, il messale nato dall’uso della chiesa romana, arricchito dalle liturgie di altre chiese occidentali ed accettato per consuetudine dalla grande maggioranza della chiesa latina, confermato per legge pontificia, si affermò (con poche modifiche) come principale testo liturgico per le celebrazioni dell’eucarestia nella Chiesa fino al 1969 [24].
III
Prescindendo dalle questioni teologiche agitate in seguito alla riforma liturgica che ovviamente non possono riguardare una indagine meramente giuridica limitata ad alcuni aspetti di questa riforma, è opportuna affrontare separatamente le questioni giuridiche che interessano:
a) la sostituzione della lingua latina con quella vernacola nell’intera liturgia ma sopratutto in quella della messa;
b) la natura e l’estensione della Costituzione Apostolica “Missale Romanum” che introduce un nuovo rito della messa.
Per quanto riguarda la lingua liturgica della chiesa latina tre sono i testi fondamentali che dal Concilio Vaticano II in poi regolano la questione ed a cui bisogna perciò fare riferimento:.
a) la Costituzione Conciliare “Sacrosanctum Concilium” [25];
b) la Istruzione “Tres abhinc annos” detta anche “Instructio Altera” del 4 Marzo 1967 [26];
e) la Notificazione del 14 Luglio 1971 [27].
Non sarebbe qui fuori luogo rammentare alcuni principi generali che regolano la potestas legislativa nell’ordinamento canonico al sommo vertice del quale il Pontefice romano (da solo o con il Concilio ecumenico) è la fonte suprema di tutte le leggi nel senso che nessuna autorità inferiore possa mai legiferare in contrasto con esso, per cui il principio generale di assoluta incompetenza del legislatore inferiore nei confronti della legge del superiore [28] si applica in modo eminente agli atti legislativi del Pontefice romano siano essi conciliari o meno. Per questo motivo la Costituzione conciliare occupa il sommo grado nella gerarchia delle fonti canoniche posto che solo un papa od un altro concilio la possono abrogare, obrogare o derogare. Nella materia oggetto della nostra indagine le Costituzione “Sacrosantum Concilium” enuncia al primo paragrafo dell’articolo 36 il principio fondamentale che regola tutta la questione della lingua liturgica nella chiesa latina: “Linguae latinae usus in ritibus latinis servetur”.
Questo principio fondamentale subisce delle deroghe nelle norme che lo seguono, ma tutte espresse precisamente, limitatamente ad alcune fattispecie e perciò mai tali da sovvertire l’enunciato del primo paragrafo dell’articolo 36 citato. Al secondo paragrafo dello stesso articolo si prescrive che potrà essere usata la lingua vernacola nella Messa e nella amministrazione dei sacramenti soprattutto “in lectionibus, in admonitionibus, in nonnullis orationibus et cantibus” secondo le norme che verranno via, via stabilite. L’articolo 54, poi, che tratta in modo particolare la materia della nostra indagine cioè l’uso della lingua volgare nella Messa, ricordando l’articolo 36 afferma che alla lingua vernacola “In Missis cum populo celebratis congruus locus tribui possit, praesertim in lectionibus et oratione communi ac … etiam in partibus quae ad populum spectant”.
Il senso pertanto della Costituzione conciliare è assai chiaro: la norma sia nella liturgia in generale che in quella della messa in particolare è la lingua latina, questa norma può essere derogata in specifiche e previste eccezioni che tali rimangono, in modo da mai sovvertire il principio generale enunciato e ribadito [29]. Questa situazione è stata modificata come abbiamo detto ad opera di successiva legislazione esattamente contraria agli enunciati conciliari.
Sul valore di questa legislazione emanata dalla S. Congregazione dei Riti prima e da quella del Culto Divino poi si è discusso assai, ma prima di affrontare anche noi la problematica relativa non sarà inopportuno ricordare le peculiarità degli atti legislativi ed amministrativi della Curia romana. Nessun dubbio che le sacre congregazioni, vicariae papae, abbiano oltre ai poteri regolamentari usualmente pertinenti ad organismi amministrativi anche poteri legislativi nonché, in determinati casi, anche poteri giudiziari. Ciò si spiega facilmente in un ordinamento come quello canonico ove non esiste, quanto meno a livello “costituzionale” (Papa-Vescovi), divisione di poteri e dove pertanto anche negli organi subordinati tale divisione non è sempre perfettamente attuata. Per tale motivo è difficile se non impossibile, nel medesimo ordinamento, stabilire una gerarchia formale delle fonti di cognizione del diritto e lo stesso nomen iuris che riveste un provvedimento di un organo non ne qualifica necessariamente il contenuto in ordine alle varie funzioni di governo. Peraltro il nomen iuris, anche se non assolutamente determinante, indica quanto meno la intentio dell’organo che lo ha emanato per cui può presumersi, fino a prova del contrario, che un determinato provvedimento appartenga all’ordine legislativo, amministrativo o giudiziario. Peraltro se quanto detto si applica in assoluto ai provvedimenti del pontefice che è libero di scegliere la forma che più gli aggrada per i suoi atti di governo diretto, tale atipicità formale non si applica con altrettanta assolutezza ai provvedimenti degli organi inferiori se non altro perché in tal caso possono esistere dei limiti formali che si traducono in “limiti sostanziali di competenza a tutela e preservazione dell’integrità stessa della plenitudo potestatis del Papa, in quanto Supremo Legislatore” [30].
Fra tali limiti vanno enumerate anche le varie forme di conferma pontificia del provvedimento del legislatore inferiore che o sanano eventuali irregolarità di forma, rendendo l’atto se non valido (che tale avrebbe potuto esserlo o non esserlo già prima) quanto meno accettabile fornendo cioè, se invalido, un titolo colorato per pretenderne l’esecuzione [31], o, con l’applicazione della forma più solenne di conferma, convalidano un atto altrimenti invalido. Le due forme di conferma pontificia degli atti emanati dagli organi di governo inferiore sono appunto la “confirmatio in forma communi” e quella “in forma specifica” [32]. Nel caso della conferma in forma comune, il provvedimento confermato, come abbiamo visto, non muta natura per cui, se l’organo di governo inferiore ha preteso legiferare ultra vires in contrasto con una precedente norma conciliare o pontificia, o comunque abbia inteso introdurre principi in contrasto con le norme suddette, lo stesso rimane invalido per la parte non conforme alla normazione superiore, mentre se la conferma sarà in forma specifica il provvedimento è perciò stesso sussunto dall’autorità superiore che lo fa proprio sanando le eventuali invalidità: si presume infatti in tal caso che l’autorità superiore sia a piena conoscenza della normazione ultra vires contenuta nel provvedimento e facendola propria voglia appunto confermarla obrogando o derogando a quanto già stabilito [33].
Nel valutare però il tipo di conferma che può aggiungersi a un provvedimento, trattandosi appunto di conferma pontificia, ci troviamo di fronte allo stesso problema della assoluta libertà del Papa di usare della formula che più gli aggrada per indicare la sua volontà, cioè ci troviamo di fronte ad un problema assai simile a quello della atipicità formale degli atti di governo pontificio: vero è che la prassi curiale ha introdotto l’uso di considerare alcune formule (ad es.: “ex certa scientia”, “ex plenitudine potestatis apostolicae”, “motu proprio” [34] come confermanti in forma specifica, ma seppure queste formule indichino un tale tipo di conferma non è detto che il Pontefice si debba limitare ad esse, per cui il problema del discrimine fra le due forme di conferma permane, risolto peraltro dalla dottrina con l’applicazione del criterio del dubbio [35] che si rifà ai principi generali dell’ordinamento: nel dubbio pertanto si presume che si tratti di una conferma comune per cui la legislazione dubbia ed indiretta del Pontefice (o comunque del superiore ecclesiastico) cede a quella diretta od indiretta chiaramente espressa dello stesso, in altre parole si ha qui l’applicazione di un principio di certezza del diritto per cui la norma certa prevale sempre sulla norma almeno formalmente dubbia.
Applicando al caso nostro i principi suesposti e considerando che le Istruzioni delle sacre congregazioni (al contrario, ad esempio, dei Decreti delle medesime) hanno in genere un carattere meramente interpretativo della legge [36] ma che peraltro ciò non impedisce che esse contegano nuove norme rispetto alla legge vigente, si nota come la Instructio Altera innovi in maniera molteplice sulle norme conciliari e soprattutto, seguendo il nostro tema, in materia di lingua liturgica rendendo facoltativo l’uso del volgare in tutte le parti della Messa [37]. La stessa Istruzione è fornita di conferma pontificia (inserita nel testo e non in calce come era altrimenti uso) con la formula: “SS. mus noster Paulus PP. VI, … praesentem Instructionem in omnibus et singulis approvavit et auctoritate Sua confirmavit… ” Ora è certo che la formula stessa indicherebbe un approfondito esame del Pontefice delle singole parti della stessa Istruzione per cui saremo di fronte ad un atto compiuto “ex certa scientia”, rimane peraltro il dubbio di una decisa volontà del Papa di far proprio il provvedimento, requisito a nostro modesto avviso fondamentale (assai più che la conoscenza del documento) per potersi arrivare a trasformare un atto casualmente legislativo di una Congregazione romana in una legge pontificia, per cui si deve nel caso presumere trattarsi di conferma data in forma comune rimanendo pertanto privo di valore quanto nella Istruzione vi sia di contrastante con la precedente legislazione conciliare.
Premesso che la Costituzione “Missale Romanum” non innova affatto in materia di lingua liturgica rispetto alla Costituzione conciliare, lo stesso problema, affrontato per la Instructio Altera, si pone in maniera ancora più semplice per la Notificazione del 14 Giugno 1971 che professa di essere una mera interpretazione, neppure della legge ma semplicemente della Istruzione “De Constitutione Apostolica Missale Romanum gradatim ad effectum deducenda” conosciuta come la Instructio “Constitutione Apostolica” del 20 Ottobre 1969 [38] (cioè per usare un linguaggio statuale: una circolare su di un regolamento amministrativo). Premesso che una Notificazione, come nel caso, più che un provvedimento anche solo interpretativo della legge è semplicemente informativo ed esecutivo di provvedimenti già esistenti, dunque un mero atto amministrativo, è da notarsi che nel caso la Notificazione stessa al numero 4 sub a) afferma: “Quoad Missas cum populo Conferentiae Episcopales ius habent decernendi de usu linguae vernaculae in quavis Missae parte”, la disposizione citata non costituisce nemmeno un tentativo di interpretazione estensiva del prescritto conciliare ma si concretizza invece in un aperto tentativo di abrogare il medesimo concedendosi dalla S. Congregazione alle conferenze episcopali un vero e proprio diritto di interdire l’uso della lingua latina durante la celebrazione della Messa, che tale è la conseguenza del diritto di imporre (decernere) l’uso della lingua vernacola in tutta la Messa (quavis parte). Sul tipo di conferma pontificia della Notificazione non vi può essere dubbio che la semplice espressione “approbante Summo Pontifice” non implicando né conoscenza del superiore né volontà di far proprio il provvedimento sottintende una conferma data in forma comune per cui non vi è alcuna adesione del legislatore alla normativa introdotta obrogante il prescritto conciliare che rimane pienamente in vigore essendo su questo punto completamente prive di legittimazione (e perciò di valore) le prescrizioni della Notificazione.
L’altro problema oggetto del nostro studio, quale sia cioè la ampiezza e la portata della riforma del messale romano attuata da Paolo VI, se essa si sia limitata a parziali modifiche del precedente testo o lo abbia totalmente (o pressoché totalmente) modificato e se ne sia risultato di conseguenza derogato, abrogato od obrogato il precedente messale frutto della consolidazione di Pio V, risulta più complesso del problema della lingua liturgica per la estrema incertezza dei testi legislativi.
Anzitutto i testi rilevanti per la nostra indagine sono:
a) la Costituzione Apostolica “Missale Romanum” del 3 aprile 1969 [39];
b) la allocuzione del Sommo Pontefice al Concistoro del 28 aprile 1969 [40];
c) la citata Instructio “Constitutione Apostolica” del 20 ottobre 1969;
d) la allocuzione del Sommo Pontefice del 19 novembre 1969 [41];
e) la allocuzione del Sommo Pontefice del 26 novembre 1969 [42];
f ) la Instructio “Liturgicae instaurationes” del 5 settembre 1970 [43];
g) la Notificatio del 14 giugno 1971 [44];
h) la Notificatio del 28 ottobre 1974 [45].
Di questi testi normativi solo il primo, la Costituzione Apostolica riveste i caratteri di norma di legge, gli altri sono atti amministrativi e anche se, come abbiamo visto, questi mal si distinguono dalla legge in un ordinamento come quello canonico, tali devonsi, nel caso presumere se non altro perché dipendono strettamente dalla Costituzione Apostolica di cui sono chiaramente interpretazione od applicazione. Da questo complesso di atti, ma soprattutto dalla “Missale Romanum”, risulta che la liturgia della messa è stata profondamente modificata, non si tratta cioè di cambiamenti di dettagli ma di una rifusione dell’intero testo, soprattutto di parti essenziali quali l’offertorio. Ovviamente molte parti della vecchia messa figurano nella nuova ma in un contesto differente, per cui può dirsi che, a parte le valutazioni teologiche del novus ordo missae che non rientrano nei fini di questo lavoro, si tratta di una messa “diversa” dalla precedente.
Si pone allora il problema, a prima vista facilmente risolvibile della portata giuridica della Costituzione Apostolica, questione che ha suscitato non poche controversie. Indubbiamente la forma è quella di una legge pontificia ma d’altra parte lo stile usato così alieno da quello normativo usuale delle leggi, la assenza di clausole imperative generali [46] salvo le clausole finali d’uso riguardanti l’efficacia dell’atto, possono far pensare ad un assenza di voluntas obligandi nel legislatore che metterebbe in forse lo stesso carattere di nonna legislativa della Costituzione [47]. Quanti meno tale potrebbe essere l’opinione di chi si fermasse a considerare la sola Costituzione Apostolica, senonché sia interventi diretti del Pontefice (allocuzione citata del 18 novembre 1969 ed in parte quella, citata, del 26 novembre 1969), sia le Istruzioni che le Notificazioni successive del dicastero romano competente, le quali costituiscono interpretazioni della legge date per modum legis [48], hanno chiarito esserci stata nel legislatore una vera voluntas obligandi e non un mero desiderio di proporre all’attenzione dei pastori e dei fedeli un rito alternativo anche se dal tenore della Costituzione parrebbe non azzardato aver supposto che la stessa vis obligandi della norma era sottoposta alla libera accettazione di essa da parte dei suoi destinatari, come del resto la dottrina ammette che possa avvenire [49].
Rimarrebbe impregiudicato il problema se debba o meno considerarsi abrogata la precedente legislazione ed in particolare la Bolla “Quo Primum” di Pio V che codificava il rito romano. Nessun dubbio peraltro che nel caso si debba, semmai, parlare di obrogazione essendo escluso il problema della semplice deroga: infatti, come abbiamo visto, la messa promulgata dalla “Missale Romanum” è completamente riformata rispetto alla precedente, si tratta effettivamente in tutto e per tutto di una “nuova” messa; se pertanto di obrogazione si trattasse (poiché di abrogazione non vi è parola nella Costituzione) essa sarebbe avvenuta in forza del . 22 perché la “Missale Romanum” ha riordinato “totam de integra prioris legis materiam [50]”. Anche qui la sostanza delle dichiarazioni del Pontefice e della normativa interpretativa e regolatrice della S. Congregazione del Culto Divino portano a concludere che vi sia stata una obrogazione della precedente legislazione (anche se il termine “obrogatio” mai appare nei suddetti documenti), per cui pare da escludere l’applicazione del c. 23 e la conseguente conciliazione fra la vecchia e la nuova legislazione rimanendo in vigore quest’ultima. Peraltro sia alcune indicazioni sulla volontà del Pontefice di non voler completamente abolire il vecchio rito romano [51] sia i persistenti difetti di legittimazione della normativa del dicastero competente in materia di lingua liturgica e, come vedremo, in materia di regolamentazione dell’uso del vecchio rito prescindendo dalla obrogazione della “Quo Primum”, possono far dubitare della completa sostituzione della vecchia con la nuova legislazione riproponendo il problema dell’applicazione del c. 23.
Prescindendo peraltro dalla questione della abrogazione o meno della bolla piana ed ammessane per ipotesi la sostituzione con la nuova legislazione, rimane da risolvere il problema se sia o meno, nel caso, avvenuta la sostituzione obrogativa del testo della nuova messa a quello precedente, cioè dell’oggetto della nuova normativa all’oggetto della precedente. Abbiamo infatti constatato nella seconda parte di questo lavoro come la messa codificata da Pio V si fosse stabilizzata in Occidente in un testo definitivo frutto di una elaborazione millenaria e retta da norme consuetudinarie per cui l’atto normativo di Pio V non aveva precedente nella storia della Chiesa: si sovrapponeva alla norma consuetudinaria una legge pontificia che avrebbe da allora in poi regolato la materia. La maggior parte della dottrina sulla scorta del Suarez [52] opina che ove una determinata materia, già regolata da norma consuetudinaria, venga regolata anche da legge scritta, quest’ultima non sostituisce la norma consuetudinaria ma si aggiunge ad essa di modo che la soggetta materia risulta regolata sia dalla norma consuetudinaria precedente sia dalla susseguente norma scritta senza che per questo ne risulti abrogata la norma consuetudinaria che continua a regolare la soggetta materia. Niun dubbio che questa opinio juris abbia influito sulla stesura del canone 30 del Codex che limita il valore obrogativo delle leggi successive nei confronti della consuetudine escludendolo sia nei casi di consuetudini particolari sia nei casi di consuetudini centenarie od immemorabili come quella di cui trattiamo. Poiché pertanto la Costituzione “Missale Romanum” forse obroga la “Quo Primum” ma certamente non abroga la consuetudine millenaria e particolare che regolava il rito della messa nella chiesa romana e latina prima della bolla piana, esso rito rimane (eventualmente anche per questo motivo) in vigore accanto al nuovo regolato dalla costituzione paolina.
Sia nell’ipotesi di obrogazione della “Quo Primum” (pur sussistendo l’antico rito vi consuetudinis), sia nell’ipotesi di un accordarsi della nuova normativa con la vecchia a norma del c. 23, risultano comunque obrogate quelle disposizioni della legislazione piana che sancivano l’esclusività del vecchio rito romano. Meno chiaro il problema della sussistenza del “privilegio” sancito dalla bolla piana e per il quale la messa secondo il rito codificato dalla suddetta bolla “absque ullo concientiae scrupolo, aut aliquarum poenarum, sententiarum et censurarum incursu”, tutti ed in qualunque luogo sacro “libere et licite uti possint et valeant” [53], necessario all’atto dell’emanazione della “Quo Primum” che prevedeva la continuata esistenza di riti bicentenari od immemorabili diversi da quello romano. Se la legislazione precedente è stata obrogata dalla “Missale Romanum” è ovvio che il “privilegio” non sussiste più come, in tale ipotesi, tutte quelle norme che non regolavano direttamente e sull’orma della precedente normativa consuetudinaria il rito della messa: infatti obrogando la bolla piana la nuova costituzione paolina avrebbe obrogato tutti i privilegi in essa contenuti, per cui non solo la messa codificata da Pio V non occupa più quella posizione di esclusività che aveva prima e che è conseguenziale ad ogni ipotesi adombrata, ma il diritto di usarne il rito non sarebbe più privilegiato come prima, ciò in virtù del combinato disposto dei canoni 71 e 22 [54]. D’altra parte una attenuazione di questo “privilegio”, se non proprio una sua estinzione, lo si avrebbe sia a causa della mutata politica liturgica della Chiesa, motivata da esigenze di uniformità al tempo di Pio V, da quelle di pluralismo oggi, sia a causa della concomitante e condizionante legislazione conciliare che attribuisce con l’art. 22 della Costituzione “Sacrosanctum Concilium” il potere di regolamentazione in materia liturgica sia alla Santa Sede (per cui alla sacra congregazione competente) sia ai singoli vescovi che alle conferenze episcopali, potere di regolamentazione che potrebbe risultare notevolmente coartato se non nullificato dalla sussistenza di certi privilegi. Anche nel caso, però, di obrogazione del “privilegio” suddetto ad opera della nuova legislazione, il potere regolamentare dell’autorità ecclesiastica infra pontificia nei confronti del vecchio rito non potrebbe spingersi fino alla pratica eliminazione della consuetudine regolante il vecchio rito e dovrebbe comunque esercitarsi in modo chiaro ed espresso, con provvedimenti legislativi che avessero tutte le caratteristiche di tali atti cioè la rationabilitas e la loro destinazione ad bonum commune promovendum [55].
Rimane da considerare la questione del continuato vigore della “Quo Primum” (e perciò dei privilegi in essa contenuti) anche nella ipotesi obrogativa, durante la vacatio legis. In tale caso, come ovvio, la legge precedente ritiene tutta la sua forza ed il rito da essa regolato la sua posizione di assoluta preminenza [56], il nuovo, poi, il cui uso è esplicitamente consentito dalla Istruzione “Costitutione Apostolica” [57] e dalla successiva Notificazione del 14 Giugno 1971 [58] (che altrimenti non avrebbe potuto adoperarsi), si pone nei confronti del vecchio rito come i riti bicentenari od immemorabili tollerati dalla “Quo Primum”. Da notare poi che la Notificazione del 14 Giugno 1971 confermata da quella successiva del 28 ottobre 1974 deroga alla Istruzione “Constitutione Apostolica” per quanto riguarda la vacatio che nella suddetta Istruzione terminava il 28 novembre 1971 e nelle Notificazioni menzionate termina invece con l’entrata in vigore delle traduzioni vernacole in ogni singolo paese senza porre una scadenza fissa, per cui l’assoluta preminenza dell’antico rito permane oggi in quelle nazioni ove non esiste ancora una traduzione vernacola ufficiale della nuova messa.
Infine resta da esaminare il valore normativo globale delle recensite Istruzioni “Constitutione Apostolica” e “Liturgicae instaurationes” nonché delle Notificazioni citate del 14 Giugno 1971 e del 28 Ottobre 1974. Devesi qui ricordare che tali atti della S. Congregazione, soprattutto le Notificazioni, si pongono come meri atti interpretativi ed esecutivi della normativa vigente [59], cioè, nel nel caso particolare, della Costituzione “Missale Romanum”: sia pertanto per questa loro specifica natura sia perché, essendo approvate semplicemente in forma comune non possono assurgere a leggi pontificie, essi non hanno potestà di derogare, abrogare od obrogare alcunché per propria autorità. Questi documenti infatti si limitano sostanzialmente ad affermare essere la “Missale Romanum” un atto normativo che intende obbligare tutti i destinatari della legge e che essa ha obrogato la Bolla “Quo Primum” obrogando altresì la consuetudine che regolava l’antico rito romano [60]. Ora se con una certa perplessità potremo consentire ai primi due assunti in quanto rientrano, almeno formalmente, nei poteri interpretativi della S. Congregazione, non possiamo assolutamente consentire al terzo perché, come abbiamo visto, il c. 30 esige una esplicita abrogazione di questo tipo di consuetudine non bastandone una implicita e meri atti amministrativi come i documenti recensiti non possono ne derogare a norme del Codice né tampoco sostituirsi al legislatore pontificio abrogando ciò che egli non ha creduto opportuno abrogare. Fedele peraltro a questa errata impostazione la S. Congregazione del Culto Divino persiste nel considerare del tutto eccezionale ed in deroga alla legge la sopravvivenza dell’antico rito romano coartandone perciò l’uso a limitatissime categorie di sacerdoti escludendone contemporaneamente il popolo [61] quando, quanto meno vi consuetudinis, libero dovrebbe esserne l’uso per tutti i celebranti ed aperta la partecipazione a tutti i fedeli.
__________________________
[1] Lo schieramento progressista aveva altri obiettivi e la maggioranza dei Padri non era ancora sufficientemente sensibilizzata su di essi per cui la discussione sullo schema liturgico servì da utile interludio.
[2] A. BUGNINI, Il nuovo “ordo missae”, in La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa, Firenze, Vallecchi, 1969, p. 520. Nel complesso, cioè calcolando oltre alle votazione del 26 Ottobre che verteva sullo schema della missa normativa anche le altre votazioni su questioni di dettaglio, si può affermare che le innovazioni nel rito della messa totalizzarono 465 voti negativi (non placet o placet juxta modum) contro 453 voti affermativi.
[3] De structura Missae: “Coena dominica sive Missa est sacra synaxis seu congregatio popoli Dei in unum convenientis, sacerdote praeside, ad memoriale Domini celebrandum. Quare sanctae ecclesiae locali congregatione eminenter valet promissio Christi ‘Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum’ (Mt. 18, 20)”.
[4] “La definizione di Messa è dunque limitata a quella di ‘cena’, il che è poi continuamente ripetuto (n. 8, 45, 55d, 56); tale ‘cena’ è inoltre caratterizzata dall’assemblea, presieduta dal sacerdote, e dal compiersi del memoriale del Signore ricordando quel che egli fece il Giovedì Santo. Tutto ciò non implica: né la Presenza Reale, né la realtà del Sacrificio, né la sacramentalità del sacerdote consacrante, né il valore intrinseco del Sacrificio eucaristico indipendentemente dalla presenza dell’assemblea. Non implica, in una parola, nessuno dei valori dogmatici essenziali della Messa e che ne costituiscono pertanto la vera definizione. Qui l’omissione volontaria equivale al loro ‘superamento’, quindi, almeno in pratica, alla loro negazione.
Nella seconda parte dello stesso paragrafo si afferma – aggravando il già gravissimo equivoco – che vale ‘eminenter’ per questa assemblea la promessa del Cristo: ‘Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum’ (Mt. 18, 20). Tale promessa, che riguarda soltanto la presenza spirituale del Cristo con la sua grazie, viene posta sullo stesso piano qualitativo, salvo la maggiore intensità, di quello sostanziale e fisico della presenza sacramentale eucaristica. Segue immediatamente (n. 8) una suddivisione della Messa in liturgia della parola e liturgia eucaristica, con l’affermazione che nella Messa è preparata la mensa dalla parola di Dio come del Corpo di Cristo, affinché i fedeli ‘instituantur et reficiantur’: assimilazione paritetica del tutto illegittima della due parti della liturgia, quasi tra due segni di eguale valore simbolico, …” (Breve esame critico del novus ordo missae – Fondazione “Lumen gentium” – Roma).
[5] Era stata precedentemente emanata, il 29 giugno 1970, una Istruzione che allargava la facoltà di ricevere la comunione sotto le due speci.
[6] G. DIX, The Shape of the Liturgy, Glasgow, 1947, pp. 50 ss.; C. RUCH, v. Messe dans l’Ecriture, in DThC X, 1, 862 e v. Messe d’après les pères, jusqu’à Saint Cyprien, op. cit., 874; J. A. JUNGMANN, Missarum Sollemnia, I, 1953, ed. Marietti, pp. 9 ss.; M. RIGHETTI, Manuale di storia liturgica, III, Milano, Ancora, 1949, pp. 4 e 19 ss.
[7] RUCH, v. Messe dans l’Ecriture, op. cit., 861; JUNGMANN, op. cit., vol. I, 19; RIGHETTI, op. cit., vol. III, 54 ss. e 58; L. DUCHESNE, Origines du culte chrétien, Paris, Thorin, 1889, pp. 45 ss.; H. LECLERCQ, v. Messe, in DAC., vol. II, 1, 532.
[8] DIX, op. cit., 48-49; RUCH, v. Messe dans l’Ecriture, op. cit., 849 ss.; JUNGMANN, op. cit., vol. I, 15-16; RIGHETTI, op. cit., vol. IlI, 8 e 140-141; LECLERCQ, op cit., 521.
[9] GIOVANNI, cap. XVII; cfr. anche RUCH, v. Messe d’apres les pères, cit., op. cit., 875; RIGHETTI, op. cit., vol. IlI, 83.
[10] DIX, op. cit., 434 ss.; cfr. JUNGMANN, op. cit., vol. I, 26 ss. e 30 ss.; RIGHETTI, op. cit., vol. III, 50 e 141; J. H. MILLER, v. Mass, Roman, in New Catholic Encyclopedia, vol. 9, 419; LECLERCQ, op. cit., 504-595.
[11] DIX, op. cit., 452 ss. e 537 ss.; cfr. JUNGMANN, op. cit., vol. II, 30 e 51; DUCHESNE, op. cit., 53-54.
[12] DIX, op. cit., 437 ss.; F. CABROL, v. Messe dans la liturgie in DTbC., vol. X, 2, 1365 ss.; JUNGMANN, op. cit., vol. I, 219 ss.; cfr. DUCHESNE, op cit., 153 ss.
[13] DIX, op. cit., 434 ss.; CABROL, op. cit., 1391; JUNGMANN, op. cit., vol. I, 377: RIGHETTI, op. cit., vol. III, 123.
[14] DIX, op. cit., 397 ss.; CABROL, op. cit., 1366 e 1388-1389; cfr. JUNGMANN, op. cit., vol. I, 91.
[15] DIX, op. cit., 565 ss.; CABROL, op. cit., 1386; JUNGMANN, op. cit., vol. I, 52 ss.; DUCHESNE, op. cit., 114 ss.; M. NOIROT, v. Liturgie (droit), in DDC., vol. VI, 540 ss.
[16] DIX, op. cit., 570 ss.; NOIROT, op. cit., 441-442; cfr. JUNGMANN, vol. I, 50.
[17] BEDA, Hist. Eccl., cap. XVII, n. 2, in P.L., T. 95, 58-59; cfr. anche: DUCHESNE, op. cit., 93-94; CABROL, op. cit., 542-543; DIX, op. cit., 570.
[18] DIX, op. cit., 570; NOIROT, op. cit., 542.
[19] DIX, op. cit., 575 ss.; MILLER, op. cit., 419; LECLERCQ, op. cit., 703 e 761; cfr. anche: NOIROT, op. cit., 543; DUCHESNE, op. cit., 97.
[20] DIX, op. cit., 578 ss.; JUNGMANN, op. cit., vol. I, 65 ss.; DUCHESNE, op. cit., 98; LECLERCQ, op. cit., 761.
[21] DIX, op. cit., 583-584; NOIROT, op. cit., 543; JUNGMANN, op. cit., vol. I, 82 ss.; RIGHETTI, op. cit., vol. IlI, 148-149; DUCHESNE, op. cit., 98; cfr. anche: LECLERCQ, op. cit., 763; CABROL, op. cit., 1402 e v. Liturgie in DThC., vol. IX, 1, 814-815.
[22] DIX, op. cit., 495; JUNGMANN, op. cit., vol. II, 35 ss. e 223-224; RIGHETTI, op. cit., vol. IlI, 158 ss. e 263 ss.; cfr. CABROL, op. cit., 1393.
[23] CABROL, op. cit., 1397; JUNGMANN, op. cit., vol. I, 102 e vol. II, 59 ss., RIGHETTI, op. cit., vol. IlI, 326 ss.; cfr. DIX, op. cit., 591.
[24] Sul carattere consuetudinario della normativa liturgica in genere ed in particolare di quella riguardante la messa prima della codificazione piana del secolo XVI, cfr., inter alia, NOIROT, op. cit., 542 ss. e 548; CABROL, v. Messe dans la Liturgie, op. cit., 1402 e v. Liturgie, op. cit., 814-815; C. VOGEL, Introduction aux sources de l’histoire du culte chrétien aux Moyen Age, Spoleto, s.d., 2 ss. e 20; DIX, op. cit., 3, 586-587, 619; JUNGMANN, op. cit., vol. I, 116 e 120; RIGHETTI, op. cit., vol. IlI, 142 e 150 ss.; DUCHESNE, op. cit., 81 ss. e 117 ss.; cfr. anche: F. A. BRUNNER, v. Roman Rite, in New Catholic Encyclopedia, vol. XII, 612; LECLERCQ, op. cit., 602 ss. e 641 ss.
Sulla consuetudine come metodo ordinario di legislazione liturgica anche dopo la codificazione piana vedi NOIROT, op. cit., 553, 555-556, 561 ss., 580, 384.
[25] Per il testo vedi “Documenti – il Concilio Vaticano II”, Edizioni Dehoniane, ed. IV, 17-95.
[26] A.A.S., 1967, 442 ss.
[27] A.A.S., 1971, 712 ss.
[28] “Principium generale est nullum legislatorem humanum aliquid posse, abrogando, mutando, vel simpliciter eludendo, in lege a superiore legislatore lata (cfr. CATHREIN, Filosofia morale, I, p. 502)”. M. CONTE A CORONATA, Compendium Iuris Canonici, I, Roma, 1950, p. 135 nt. 2.
[29] Tale interpretazione è avvalorata dalle relazioni che accompagnarono lo schema della Costituzione conciliare. Nella relazione di Monsignor Iesus Enciso Viana, Vescovo di Maiorca, così si legge: ” … 2) Alii, e contrario, indicant integram Missam dicendam esse lingua vernacula. Sed linguam latinam penitus exulare a Missa contradicet principio iam statuto in art. 36. 3) Videtur potius incedendum esse via media, quae iam in schemate designata est, et ad quam plures Patres, etsi diversis gradibus, accedunt … Ut hoc obtineremus: A) voluimus ita loqui ut illi qui desiderant totam Missam latina lingua celebrare, opinionem suam aliis non imponant; et similiter qui in quibusdam Missae partibus lingua vernacula uti volunt, ad suam praxim priores non coerceant. Ideo, iuxta ea quae in art. 36 statuta fuerant, linguae vernaculae congrum locum concedimus, sed non dicimus tribuatur sed tribui possit, id quod iam in laudato art. 36 curatum est. Nemini, ergo, porta clauditur, ut si velit totam Missam latina lingua celebret; et nemini clauditur [162/163] porta ut in quibusdam partibus Missae vernaculam linguam adhibeat”. (Acta Concilii Vat. II – Vol. II . Pars II – 290-291).
Nella relazione di Mons. Carlo Giustino Calewaert, Vescovo di Gand, cosi si legge: “… Duas enim partes simili tenet articulus noster, et principem locum linguae latinae, et aliquem locum linguae vemaculae assignandum” (Acta Concilii Vat. II – Vol. I – Pars IV – 285, n. V).
[30] Cfr. M. GORINO CAUSA, Sui regolamenti in diritto canonico, Torino, Giappichelli, 1954, p. 66.
[31] WERNZ-VIDAL, Jus Canonicum, I, Romae, 1952, p. 218.
[32] P. MONETA, Il controllo giurisdizionale sugli atti dell’autorità amministrativa nell’ordinamento canonico, I, Milano, Giuffrè, 1973, p. 81, cfr. in nt. 41 nella stessa pagina la bibl. cit.
[33] Non si comprende peraltro la necessità di questa presunzione per quanto riguarda il requisito della conoscenza integrale del provvedimento da parte dell’autorità superiore bastando a nostro avviso la semplice volontà di quest’ultima, chiaramente manifestata, di voler far proprio il provvedimento in tutto e per tutto.
[34] M. CONTE A CORONATA, Institutiones Juris canonici, I, Taurini, 1928, p. 391, n. 335. nota 4.
[35] J. TORRE, Processus matrimonialis, Neapoli, 1956, pp. 8-9; G. MICHIELS, Normae generales Juris Canonici, II², Parisiis, Desclee, 1949, p. 537; cfr. anche c. 15 C. I .C.
[36] “Sunt ex hoc documento interpretativae iuris clari, non dubii; exsecutivae insuper et completivae iuris constituti; unde legem quam complent et exsecutioni mandant derogare non possunt; unde si cum lege componi nequeunt, huic insistendum tametsi sit anterior instructioni”. (WERNZ-VIDAL, op. cit., p. 279 nt. 56). Sulla efficacia assai limitata di tale categoria di atti cfr. anche TORRE, op. cit., p. 7.
[37] L’interpretazione estensiva, nel caso, si concreta in un tentativo di normativa in contrasto con la precedente.
[38] A.A.S., 1969, 749 ss.
[39] A.A.S., 1969, 217 ss.
[40] A.A.S., 1969, 425 ss.
[41] A.A.S., 1969, 777 ss.
[42] Osservatore Romano, 27 novembre 1969, anno CIX, n. 274.
[43] A.A.S., 1970, 692 ss.
[44] A.A.S., 1971, 712 ss.
[45] In “La Civiltà Cattolica”, 1° marzo 1975, p. 481.
[46] Le uniche clausole imperative, particolari peraltro e non generali, contenute nella Costituzione Apostolica, riguardano l’introduzione di nuovi canoni o preci eucaristiche e soprattutto la forma dell’istituzione eucaristica o formule consacratorie.
Una certa controversia è nata sul valore dell’espressione: “A extremum, ex iis quae hactenus de novo Missali Romano exposuimus quiddam nunc cogere et efficere placet” (tradotta erroneamente nell’edizione vernacola della Costituzione: “in fine … vogliamo dar forza di legge”, quando il vero significato dell’espressione “cogere et efficere” è: ” … vogliamo trarre alcune conclusioni”) in cui alcuni hanno voluto vedere una inesistente clausola imperativa.
[47] Cfr. MICHIELS, op. cit., I, p. 291; WERNZ-VIDAL, op. cit., T. I, 150.
[48] c. 17, par. 2, C. I. C.
Anche se per il rinvio operato del canone 2 il diritto liturgico trovasi per la maggior parte contenuto in autonome tonti di cognizione, ciò nonostante si basa, come il restante diritto della Chiesa sulle stesse norme fondamentali del libro I del Codex fra cui quelle che regolano la materia delle leggi e delle consuetudini (cfr. MICHIELS, op. cit., I, p. 62).
[49] MICHIELS, op. cit., vol. I, 197.
[50] Cfr. Allocuzione pontificia cit. del 28 Aprile 1969, in A.A.S, 1969, 428.
[51] Cfr. lettera del Cardinale Heenan al sig. Houghton Brown, presidente della Latin Mass Society, del 22 Novembre 1971, in Notiziario n. 8 di “Una Voce” – Associazione per la salvaguardia della liturgia latino-gregoriana – tip. Pedanesi, Roma, Marzo 1972, p. 10. [cfr. www.unavoce-ve.it/unavoce-italia=lettera_cardheenan22-11-71.htm NdR]
[52] CICOGNANI-STAFFA, Commentarium in librum I Codicis, Romae, II, pp. 19-20 nt. 4:
“Quaeritur: si consuetudo juridica a legislatore in scriptis redigatur nec tantummodo approbetur et subditis commendetur, sed per veram legem tamquam obligatoria proponatur, manetne vinculum consuetudinis cui additur [169/170] vinculum legis scriptae, aut consuetudo in legem scriptam mutatur eique locum et vim cedit? Censemus vinculum consuetudinis simul cum vinculo legis scriptae permanere. (Cfr. F. SUAREZ, De Legibus, L. VII, c. 2, n. 4; G. MICHIELS, Normae Generales, II, p. 8; contra A. VAN HOVE, De Consuetudine et de temporis supputatione, n. 3). Nostram sententiam quidam textus confirmant: e.g. c. 2, III, 4, in VI; c. 3, IV, 18, in VI: cfr. etiam Benedictus XIV Constit. “Singulari” d. 9 februarii a. 1749 par. 10 apud Gasparri, Fontes, 2, n. 394, p. 196. Plures insuper decisiones Romanae Curiae consuetudine, praeter quam lege, innixae sunt, etiam postquam consuetudo lege firmata fuerat (cfr. ex. g. A.A.S., 1914, p. 556; A.A.S., 120, p. 134). Quaeri etiam potest utrum consuetudo, per subsequentem legem firmata, vim suam amittat abrogata lege. Distinguendum videtur: si agatur de consuetudine universali cui accedit lex scripta, abrogata lege videtur abrogata etiam consuetudo, quia iam patet voluntas legislatoris novam ubique inducendi disciplinam, secus abrogatio legis vim ac sensum non haberet; si vero agatur de consuetudine particulari cui accedit lex scripta universalis, abrogata lege universali non censetur abrogata antecedens consuetudo particularis (cfr. F. Suarez, l. c.): e. g. si ante Codicem habebatur consuetudo particularis centenaria vel immemorabilis cui accesserat lex universalis et haec sit Codici contraria, lex generalis vi c. 6 n. I est abrogata dum e centra tolerari potest consuetudo particularis, vi c. 5, si Ordinarius pro locorum ac personarum adiunctis existimet eam prudenter submoveri non posse: cfr. Vol. I p. 73-74″.
[53] Missale Romanum ex decreto sacrosanti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificies Maximi jussu editum etc., Romae, Tornacii, Parisiis, 1942, p. IV.
[54] MICHIELS, op. cit., vol. II, 600 ss.
[55] MICHIELS, op. cit., vol. I, 154 ss.
[56] Cfr. MICHIELS, op. cit., vol. I, 675.
[57] A.A.S., 1969, 751 n. 9.
[58] A.A.S., 1971, 713 n. 1.
[59] MICHIELS, op. cit., vol. I, p. 503; M. GORINO CAUSA, op. cit., pp. 16 ss.
[60] Cfr. Notificazione del 28 Ottobre 1974 cit.
[61] La Istruzione “Constitutione Apostolica” limitata ai soli sacerdoti “aetate provecti” che celebrino “sine populo”, l’uso dell’antico rito con possibile estensione a sacerdoti infermi “aut aegritudine vel aliis difficultatibus laborantium”. La Notificazione del 28 ottobre del 1974 allarga peraltro le categorie a cui sarebbe concesso, in via sempre di eccezione, l’uso dell’antico rito comprendendo senz’altro (e non solo come oggetti di possibili singoli indulti) accanto ai sacerdoti anziani anche quelli che per infermità “graves experiuntur difficultates in Novo Ordine Missalis Romani vel Lectionarii Missae servando”. Dobbiamo pensare che una simile resipiscenza del dicastero romano dimostra che ci si è accorti di non poter impunemente violare la legge vietando ciò che il legislatore pontificio aveva lasciato sussistere?
Inoltre la messa “sine populo”, introdottasi in occidente nel tardo medioevo come necessità per venire incontro alle celebrazioni individuali, può essere vista sotto l’aspetto di eccezione non come norma e ciò per la celebrazione di qualsiasi messa: vista come norma contraddice al concetto di sacrificio offerto per il popolo insieme al popolo che sta alla base dell’intero “aggiornamento” liturgico voluto dal Vaticano II.
da: «Archivio Giuridico Filippo Serafini» CXC (1976), pp. 147-173.